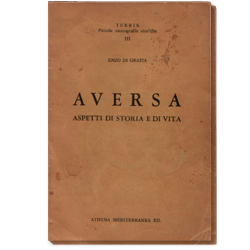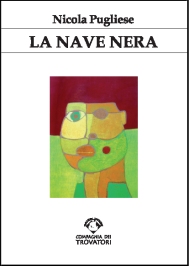La Nave Nera – il racconto che dà titolo al libro – è un moderno manifestarsi della leggenda dell’Olandese volante, il misterioso vascello fantasma che nei due secoli scorsi fu tante volte avvistato in diversi punti del globo. Una Nave Nera, di notte, solca le acque del Golfo, e la sua realtà prende corpo dalle testimonianze di quanti hanno potuto vederla veleggiare, sospesa sopra la superficie del mare, apparizione tesa a scompigliare le regole del vissuto. Nulla di essa è rimasto se non l’idea scioccante del suo esserci stata, buona a frantumare ogni credenza consolidata, fisica quanto individuale.
>>>
“Tanto per cominciare, non tutti concordano sul fatto che la Nave sia “scivolata”: secondo alcuni, tranquillamente, solcò le onde come nave che solchi, secondo altri solamente sfiorò il filo dell’acqua, restandone comunque distinta, e sospesa comunque tra cielo e mare, per quanto – ovviamente – piú vicina al mare, e propriamente, come accennato, al filo dell’acqua e non soltanto in queste due ipotesi poteva riassumersi la gamma intera delle congetture, ma in una rosa molto molto piú vasta, vastissima, diciamo innumerabile, a dire il vero, ma le testimonianze non possono essere riportate tutte: quale valore avrebbe 1’urlo di un bambino?, lo sguardo nero d’una donna che restò in silenzio?, lo sputo incredulo d’un vecchio?, quale valore avrebbe il racconto preciso d’un testimone preciso?, e a dirla proprio tutta: quale valore, anche, può avere questa narrazione che ora se ne fa?”
Otto caustici racconti costituiscono il volume (Compagnia dei Trovatori, 2008 – pp. 88, € 12,00), otto graffianti illustrazioni di una Napoli che mai finisce di stupire, sempre diversa nel resoconto che ciascuno dei suoi figli, mosso a parlarne, consegna ai contemporanei, rispettoso, pur avendo sollevato un altro lembo del manto che ricopre indulgente la grande madre. Nicola Pugliese, milanese solo di nascita, ritorna al pubblico 32 anni dopo il suo esordio con il romanzo Malacqua, ed è un ritorno decisamente positivo.
La prosa di Pugliese è di una originalità estrema, farcita di domande che non pretendono risposta ma che hanno l’effetto di trasferire il lettore dentro il racconto per renderlo personaggio, di più, protagonista. Si stabilisce allora una fluida comunicazione tra le due entità contrapposte, scrittore e lettore. E allorché il primo effettua la mossa, il secondo è coinvolto nel movimento, e il suo interesse diviene mezzo e prodromo per ogni sviluppo successivo. Lo scrittore gioca sulle alternanze, le ripetizioni rafforzative, una sorta di andirivieni che affina ed arricchisce – ad un tempo – il concetto espresso, a diritto e a rovescio, quasi una pallina di ping-pong oscillante da un campo all’altro, e il narrato si dipana in sfumature nuove via via più coinvolgenti. L’effetto è univoco: la trama diviene sussidiaria, poco importante, un dettaglio. Le oscillazioni risvegliate nel nostro pensiero, intanto, saturano la pagina e, senza sussulti, il miracolo si compie: da passivi lettori ci troviamo al fianco dell’Autore, identificandoci in ciò che viene creando.
Ecco dunque che noi siamo Andreoli Carlo – il protagonista del bellissimo “La morte a Ferragosto” – che legge dalle pagine del quotidiano appena acquistato la storia di quel suo stesso giorno, in un’identità sconcertante, attraverso la quale realtà e finzione letteraria si saldano in un cerchio perfetto al quale non può sfuggire. E il suo futuro viene a coincidere, imperscrutabilmente, con la fine del racconto.
Eccoci nei panni di Annunziata Osvaldo, che percorre tutte le tappe di una piramide aperta, nell’ascensione al potere all’interno di una Grande Fabbrica. È un alienato fino al midollo senza sapere di esserlo.
Eccoci ancora Monetti Paolo, a cui tocca, regalo per l’anno nuovo, un’agenda decisamente singolare.
Ecco macchiarci della peggior colpa, il parricidio, come il protagonista de “Il prigioniero”: “Uccise il padre, in quella notte d’innaturali silenzi, col vento dei pensieri che turbinava e turbinava. Uccise il padre sparandogli sul cuore, con questo sangue scuro che veniva e veniva, maledizione inappellabile, biblica sentenza, uccise il padre sparandogli sul cuore nel silenzio protettivo della notte, come omosessuale vigliacco.
Uccise il padre perché gli somigliava troppo, troppo in un modo indecente: si può sopportare per anni diversità anomala e nemica, non certo somiglianza condiscendente e complice. Uccise il padre che gli diceva sempre di non correre, che la vita è breve, la vita è limitata, al di là di quel certo limite non si può spingere, non c’è alcunché, al di là di quel certo limite, e quindi se si trattava – come indubitabilmente si trattava – di prefissati e predeterminati confini, inutile correre, inutile affannarsi.
Uccise il padre, in quella notte densa di grida, di urla, di scomposte invocazioni d’aiuto, di sangue raggrumato e spento, spento per sempre, soprattutto perché il padre gli aveva detto: «Tu non sarai mai, nella tua vita, un uomo dawero libero. Ci sarà sempre un muro a sbarrarti il passo».
E questo soprattutto non gli andava giú: questo fatto che lui non sarebbe stato mai e poi mai un uomo libero, perché a dire il vero la pensava differentemente: con la forza dei vent’anni, con quella volontà determinata e ferma, con la fiducia che riponeva in sé, con la consape-volezza responsabile della propria volontà tesa come arco a tendere, si rifiutava di pensare, in effetti, che qualcosa o qualcuno avrebbero potuto limitare o condizionare la libertà sua, quella che gli gonfiava il petto e i muscoli della braccia, quella che premeva alle tempie e sul cuore: determinazione inarrestabile. Fu soprattutto per quest’ultimo motivo, complesso e semplice al tempo stesso, per questo motivo che lo feriva come ferito a morte, che in quella notte di innaturali silenzi, con un colpo dentro il cuore, egli uccise il padre.“ e siamo ignavi tal quale il figlio colpevole, prigioniero per tutta la vita di se stesso più che di altri.
E siamo ancora Andreoli Carlo – stesso eppur altri – quando “considerò in silenzio le strade antiche di questa città che gli era cresciuta addosso … ed oltre ed oltre, nella distesa disarticolata delle luci si poteva scorgere il mare, e questa presenza lui l’avvertiva bene: per le vie del Vomero, dentro luci sfrangiate e segmenti, la presenza del mare stava là come carezza consolatoria, un’ipotesi di riscatto: e pure per qualche verso c’era da domandarsi: sarebbero mai riusciti gli uomini ad arrivare al mare?” cittadino frastornato, alla rincorsa di un amore che per quanto vicino non potrebbe essere più remoto, tutto lo lascia sgomento, incerto sul da farsi, abbandonato a pellegrinaggi notturni senza costrutto… fragile fuscello sballottato su e giù dalle onde della vita, forse ancora più grosse nel denso marasma che lo circonda.