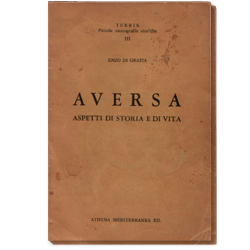“L’ombra
più lunga” – un precedente lavoro del 2009 di Gianfranco Pecchinenda – era
incentrato sulla relazione padre-figlio, cioè sull’eredità pesante che, dalle
spalle paterne, scende a volte benefica a volte troppo onerosa, su quelle dei discendenti,
in specie del figlio maschio. Con questa opera egli invece tratta
dell’influenza materna, un’ombra ancora più lunga. L’Autore, napoletano
cresciuto in America Latina, già Preside della Facoltà di Sociologia presso la
Federico II di Napoli, è docente di Sociologia dei Processi Culturali e
Comunicativi, e ha pubblicato numerosi saggi e testi nel campo professionale.
>>>continua>>>
Tutta
la narrazione è un’elegia in memoria, ma cambia decisamente registri in questo contesto. Si inizia per interposta
persona: è un amico colto nel momento in cui ha notizia della perdita della
madre e subito si è “in medias res”. La morte raggiunge il figlio lontano, a
Parigi, e la profondità della ferita è come alleviata dalla lontananza e dai
febbrili preparativi per l’immediato rientro:
“…tra una lacrima e l’altra che proverò a nascondere a mia moglie e ai miei figli, ripenserò che anche questa,
la circostanza di morire mentre mi trovavo a Parigi; proprio qui da queste parti, dev’essere stata una sorta di
regalo che mi hai fatto, un ultimo regalo.
Dovendo
morire – e sono sicuro che avresti voluto evitare di farmi questo torto, che
sei morta perché sei stata costretta a farlo – dovevi comunque trovare il modo per non farmi soffrire troppo, o
comunque volevi provare ad addolcire
l’evento, a dargli un senso. È stato
un ultimo regalo che non potrò
dimenticare e che anzi si rinnoverà ad ogni mio passaggio per questi luoghi.”
La
scomparsa di un genitore spinge con immediata brutalità sul sottile bilico tra l’esistenza
ed il suo venir meno. Quando si tratta dell’ultimo dei due, scompare con lui
l’intera prima parte della nostra vita: non saremo più bambini, né adolescenti,
né protetti da un fermo baluardo contro ogni attentato, non potremo mai più
nella nostra vita “essere figli”!
Ci
affacciamo, sgomenti, sul dopo, preda dei timori che nascono quando non
sappiamo cosa c’è dietro questa svolta capitale. Ritti sulla soglia, perdono
importanza luogo e tempo, e la metafora nel testo dell’orologio senza lancette
ben rappresenta il vuoto essenziale, un territorio in cui ci si aggira senza
riferimenti. La perdita delle relazioni spaziali diviene naturale, non causa
scompensi, imbarcati come si è sulla nave dei ricordi che veleggia in un
universo a parte, e non ha limiti per ripresentarci intatte, fresche, incuranti
degli anni o dei decenni trascorsi, immagini di località remote,
geograficamente e non, inondandoci delle sensazioni e delle emozioni di allora.
Ci si perde, tra ricordi e persone che non sono più, che ci sono passate
accanto, in maniera più o meno toccante, che hanno condiviso vicende e
sentimenti più o meno intensi, annaspando, ciascuno per proprio conto,
nell’informe sacco della vita recato appresso, riempito giorno dopo giorno
delle tante cose che agitano il nostro andare.
L’amante
paterna, tale o presunta, la zia casalinga, suo marito patito del pugilato, i
parenti persi nei giorni, gli amici di un giorno o di anni, gli affetti fondati
su minuzie, fantasmi di fatti e persone dispersi lungo le strade della vita, le
memorie insomma, si affollano in ricchezza e povertà, lasciandoci ad un tempo
saturi e insoddisfatti. Cosa di meglio vi avremmo potuto cogliere e non ci
siamo riusciti? Quale argine può porre il tempo dinanzi all’onda travolgente
dei ricordi? Si affollano, divengono esigenti, il terribile lutto familiare
pare averli rinvigoriti, aver dato loro una possanza mai posseduta, nemmeno
all’atto del verificarsi, del divenire realtà di attimi, di giorni, di mesi,
magari di anni. Il rischio terrificante è rimanere schiacciati sotto questa
mole incombente di un io, uguale e diverso, dove è facile perdere ogni
caposaldo, persino smarrire se stessi.
“Tua
madre però entrò improvvisamente nella stanza
e ti ricordò che era giunta l’ora di andare; avevate ancora tante cose da fare, e il tempo non era infinito. E lei forse per questo aveva sempre
fretta. Il tempo non è mai infinito,
per nessuno. Lo sapevate entrambi.
Solo che il giovane che eri allora, non
aveva ancora preso piena coscienza che il vissuto temporale è una questione puramente interiore; che invecchiando il tempo scorre sempre più velocemente,
un po’ come accade con le clessidre, in cui
i granelli di sabbia, sfiorandosi di continuo, diventano sempre più lisci e microscopici,
giungendo a passare da un lato all’altro dello strumento quasi senza frizione: quanto più vecchia è la
clessidra, insomma, tanto più velocemente scende la sabbia.”
E
poco importa, in ultima analisi, distinguere tra realtà e fantasia, tra verità
e finzione. Il credere fermamente che una cosa sia accaduta le dà uguale
consistenza che l’averla solo immaginata. “La vita è sogno” titolava
Calderon de La Barca, e non è assurdo bordeggiare i propri giorni lungo un
diffuso crepuscolo che lascia l’ambiguità d’intenderlo giorno oppure notte. Del
resto, sostiene Umberto Eco nel suo ultimo romanzo – “Storia delle terre e
dei luoghi leggendari” – che la verità della realtà umana è del tutto
relativa. Essa spesso può essere smentita da eventi successivi. L’unica verità
inalterabile è solo quella romanzesca: che il Raskolnikov di “Delitto è
castigo” sia un omicida rimarrà immutato in tutto il tempo a venire…
Il
figlio rimane tramortito sotto questa onda di piena e tutto diventa una
reazione salvifica che lo aiuti a metabolizzare il lutto, a superare in qualche
modo il dolore che altrimenti lo
travolgerebbe. Fantasia, finzione, realtà, caratteristiche del mondo dei
vivi che non portano avanti di un passo nella conoscenza di quello dei non più
tali.
Nell’indefinito
tra veglia e sonno – l’unica “imago mortis”, quest’ultimo, che ci è dato
conoscere – ecco che la narrazione si trasferisce in prima persona. Lo
scrittore si fonde con l’amico e divengono un tutt’uno. Si sono sdoppiati per
un solo scopo, sempre uguale: moltiplicare le forze dinanzi la tragedia.
La
vita è come la letteratura, un po’ vera, un po’ finzione. Non possiamo
costruirle come le vorremmo, esse si fanno avanti da sole. A volte impongono
quello che mai avremmo scelto. E l’Autore si spinge a ipotizzare variazioni, ad
indagare sulle cause della sua condizione presente, di chi è stato merito o
colpa, quali avrebbero potuto essere le alternative: migliori del caso
fortunato che si è trovato a vivere o, più probabilmente, peggiori se qualcosa
non fosse andato per il giusto verso. Se, in fondo, sua madre non si fosse
tanto adoperata per farlo divenire quello che oggi è. E i troppi ricordi –
quali che siano – orfani del viso di lei, della sua persona, delle sue parole,
avrebbero potuto mutare sostanza in sua presenza.
Il
libro si rivela uno sforzo prolungato di mantenere “VIVA” la genitrice
attraverso fatti, immagini, eventi vissuti insieme, travisamenti di fantasie
pensate reali perché sarebbe stato bello che tali fossero. Tutto per far sì che
la potenza dei ricordi spenga il dolore che, al sopravvenire della coscienza
della morte, si spande, contaminando di gelo tutto il dentro. La narrazione è
un epicedio che vuole fugare l’oblio, il risultato peggiore che possa capitare,
peggiore della stessa scomparsa, per tutto quello che è stato un uomo nel corso
della sua vita. È qui è facile citare il Foscolo dei “Sepolcri“: “Sol chi non
lascia eredità d’affetti poca gioia ha dell’urna”.
Vengono
citate le parole di Vargas Llosa, in occasione del discorso per il conferimento
del Premio Nobel:
“uno
dei motivi per cui vale la pena vivere è anche solo per il fatto che senza la
vita non potremmo leggere e nemmeno inventarci storie”
Per
l’Autore, nel filone, uno dei motivi principali del vivere, del progettare un futuro,
potrebbe essere il desiderio di sapere come andranno a finire le tante storie
di cui è intessuta la nostra vita o, più in generale, il desiderio di
alimentarsi di “storie”. Cosa che oggi, purtroppo, tanti, troppi, soddisfano
solo attraverso la tv, mentre le parole – lette o scritte, sussurrate o parlate
– possono essere la più forte muraglia contro le angosce del silenzio.
La
prosa di Pecchinenda è spessa e meditata, il libro è pieno di citazioni
letterarie. Queste, di autori celebri e meno, vengono poi argomentate con
tratti propri e collegate a vicende dirette: dell’uomo? del personaggio? non fa
alcuna rilevanza. La narrazione sgorga dalle profondità dell’essere e reca in
superficie ansie, timori, ricordi belli e tristi, una sorta di camino vulcanico
che dà modo all’interno magma di sfogare a tratti, alleviando la dirompente
tensione.
“Ma
quali sono, mi chiedo, i giorni della nostra vita che non dimenticheremo mai?
Quali, tra i tanti trascorsi con le persone amate, quelli che ricorderemo per
sempre? E perché proprio quelli e non i mille possibili altri?”
Le
incognite della vita prendono il sopravvento, come è naturale che sia. I grandi
dolori non ci stroncano – fortunatamente – e, nel caso migliore, possono essere
un punto fermo che ci inviti a rivisitare molte delle nostre cose.